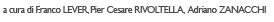Macchina fotografica
- Testo
- Bibliografia14
- Links4
- Voci correlate
Autore: Franco Lever
È uno strumento costruito secondo il modello della camera oscura, in grado di fissare l’ immagine che si forma al suo interno.
Dopo la m.f., per le stesse informazioni di tipo visivo sono arrivati la cinepresa e l’ ologramma; per le informazioni sonore il microfono, il disco, il registratore, il CD, il MiniDisc; per le informazioni di tipo ottico e uditivo insieme, la telecamera e la televisione, con il videoregistratore, analogico prima e poi digitale.
Con il miglioramento della strumentazione la m.f. ha di fatto allargato il campo visivo dell’uomo: non solo perché gli ha consentito di osservare con molta più accuratezza moltissimi fenomeni, ma perché lo ha messo in grado di esplorare l’immensamente piccolo, come l’immensamente grande, assumendo punti di vista altrimenti impossibili (gli esami endoscopici, ad esempio, oppure il controllo di situazioni pericolose); ha reso ‘visibili’ fenomeni che si verificano in tempi brevissimi, dilatandone in forma virtuale la durata o, viceversa, fenomeni lentissimi concentrando in brevi sequenze quanto avviene in giorni o mesi. Della tecnica di riproduzione fotografica – ingrandimento e riduzione – non ha beneficiato soltanto la stampa in tutte le sue forme, ma anche la tecnica, in modo particolare la microelettronica per la produzione dei circuiti integrati che rendono ‘intelligenti’ le macchine oggi a nostra disposizione (non solo i computer, ma tutte le macchine con forme di autocontrollo, dalla lavastoviglie al videoregistratore).
a) La camera oscura era un fenomeno conosciuto da oltre un millennio. Divenne oggetto di interesse crescente quando il pensiero filosofico e scientifico occidentale – è l’età del rinascimento – adotta una concezione che pone al centro dell’universo un solo punto di vista, quello dell’uomo, inteso come misura di tutte le cose (nasce la scienza moderna). La prospettiva diventa l’unico modello di rappresentazione della realtà, inteso come struttura geometrica che organizza ogni informazione visiva. Il fatto che la camera oscura desse un’immagine della realtà giudicata perfetta, e questo in modo automatico, ha determinato il successo di questo strumento presso tutti gli interessati a usare il disegno per memorizzare un’esperienza visiva. La conseguenza è stata che il modello prospettico è diventato per l’Occidente lo schema visivo naturale, scientifico: rappresentare la realtà in modo diverso è semplicemente sbagliato. Di qui la reazione degli artisti della seconda parte del secolo scorso e di questo secolo, i quali hanno disatteso e reinterpretato le leggi della prospettiva per esprimere modi diversi di sentire la realtà. Come conseguenza si consolida la convinzione che la fotografia connota oggettività, verità, mentre l’arte è considerata operazione soggettiva, astratta, effimera.
b) La stampa a caratteri mobili – con nuove forme di utilizzazione della xilografia prima e della litografia poi per la produzione delle immagini – aveva già messo a disposizione la tecnica per produrre non dei singoli esemplari ma un numero indefinito di copie perfettamente uguali una all’altra ( Tipografia). Il punto di partenza rimane però sempre l’opera di un artista o di un tecnico, il quale pazientemente sa riprodurre i tratti di un disegno o di una pittura in righe e superfici in rilievo, dove l’inchiostro si ferma in modo da impregnare poi la carta.
c) Alla fine del Settecento e all’inizio dell’Ottocento sono molti coloro che si pongono il problema della riproduzione automatica del disegno o dell’immagine che si ottiene sul fondo della camera oscura. E questo è importante, perché il primo passo di ogni invenzione è la corretta formulazione del problema. Così il litografo era alla ricerca di un metodo che gli consentisse di trasferire automaticamente un’immagine sulla pietra (i fratelli Niepce, fisici e chimici francesi, lavoravano, tra l’altro, al miglioramento del processo litografico, introdotto in Francia nel 1815); c’era chi utilizzava la camera oscura per riprodurre un paesaggio su tela o per dipingere i fondali di uno spettacolo teatrale (il Diorama di Daguerre a Parigi si basava su giochi di luci e trasparenze di scenari riproducenti paesaggi concreti, riconoscibili); c’era anche chi, senza riuscirci troppo bene, utilizzava la camera chiara per documentare i suoi viaggi (era il 1833 quando l’inglese Talbot, di fronte alla bellezza del lago di Como e alla propria incapacità di tradurre lo spettacolo in un disegno, decise di studiare come ottenere immagini in modo ‘automatico’).
d) La scienza già da tempo aveva individuato alcuni fenomeni risultati poi decisivi. Che i sali di argento si annerissero sotto l’effetto della luce lo si era osservato già nel 1560; la prova era stata ottenuta da J. H. Schulze nel 1727; anche l’effetto di indurimento provocato dalla luce sul bitume di Giudea non era una novità; che l’iposolfito di sodio sciogliesse i sali di argento l’astronomo e scienziato J. F. W. Herschel l’aveva notato nel 1816.
All’inizio del sec. XIX, dunque, c’erano a disposizione tanti tasselli privi di relazione tra loro. Attraverso prove ed errori, risultati perseguiti intenzionalmente oppure ottenuti in modo casuale, suggerimenti e veri furti di idee, quei tasselli si sono riuniti a formare un puzzle sempre più coerente ed efficace, riuscendo a definire il processo fotografico.
Probabilmente sono invece Joseph-Nicéphore e Claude Niepce i primi a ottenere dei risultati concreti e stabili. Essi già dal 1815 stanno lavorando su un procedimento che chiamano ‘eliografia’ (scrittura del sole) sia per riprodurre ‘automaticamente’ un’immagine come matrice per il processo litografico, sia per fissare l’immagine che si forma nella camera oscura. La loro ricerca e gli esperimenti continuano fino al 1833, data della morte del più attivo dei due fratelli, Joseph-Nicéphore. Del 1827 è la loro eliografia più bella a noi pervenuta, in cui è ripresa una tavola apparecchiata (per ottenere quell’immagine fu necessaria un’esposizione di otto ore).
Un altro francese, Louis Jacques Mandé Daguerre, usa la camera oscura per disegnare i fondali del suo spettacolo. Nel 1827 viene a sapere – dal tecnico che gli fornisce l’apparecchiatura – degli esperimenti e dei risultati dei Niepce. Si dà da fare per incontrare Joseph-Nicéphore, mentre è a Parigi di ritorno da un viaggio in Inghilterra. Quando sa che sta per pubblicare un libro sulle sue ricerche lo sconsiglia e, millantando successi suoi nello stesso ambito, riesce a convincerlo a fondare una società (la Niepce-Daguerre) per sfruttare un’invenzione che pensa già a portata di mano. Gli esperimenti continuano senza veri progressi, anche dopo la morte di Niepce. Il problema insoluto è sempre lo stesso: come far durare l’immagine, bloccando l’effetto della luce sui sali d’argento? In pratica l’immagine si forma, ma deve essere osservata nella penombra e, in ogni caso, dopo un certo tempo, essa viene cancellata dall’annerimento di tutta la superficie. Nel 1837 Daguerre risolve in parte il problema e ottiene delle immagini particolarmente valide per l’esattezza dei particolari e per l’ampia gamma di grigi con cui sono riprodotte luci e ombre. Nel 1839 annuncia l’invenzione come se fosse soltanto sua e, grazie all’appoggio di François Arago, segretario dell’Accademia delle Scienze e deputato, ottiene dal governo francese un sostanzioso vitalizio in cambio della pubblicazione dell’invenzione presentata come una grande conquista della scienza francese.
Il dagherrotipo – come Daguerre si affretta a chiamare il nuovo tipo di immagine – è una lastra di rame, argentata e tirata a lucido; viene esposta a vapori di iodio (la superficie si modifica in uno strato sottilissimo di sali di argento) e quindi inserita nella camera oscura, per la ripresa vera e propria, per un tempo non particolarmente lungo. L’immagine che si forma sulla sua superficie non è immediatamente visibile; lo diventa sotto l’effetto del vapore di mercurio, che si amalgama all’argento prodottosi sulla lastra per effetto della luce. Il tutto viene immerso in una soluzione concentrata di sale marino che si è dimostrato capace di ridurre notevolmente la fotosensibilità dei sali d’argento rimasti sulla lastra. Il risultato è un’immagine impressionante per il dettaglio e la resa dei contrasti luminosi; è tuttavia visibile solo se si inclina la lastra secondo un certo angolo rispetto alla luce. È un esemplare unico, non moltiplicabile. Per questo la soluzione proposta da Daguerre non può essere considerata a tutti gli effetti l’invenzione del processo fotografico, il quale consiste in due fasi tra loro complementari: la produzione dell’immagine e la sua riproducibilità in tanti esemplari, tutti identici.
In quelli stessi anni in Inghilterra lavorava alla soluzione del problema anche W. H. Fox Talbot. Seguiva però un procedimento assai diverso. Nella camera oscura esponeva alla luce un foglio di carta preparato con un preciso procedimento: dopo essere stato immerso in una soluzione di sale marino, una volta asciutto veniva imbevuto di una sospensione di sali di argento. Per quanto riguarda la produzione dell’immagine, Talbot aveva ottenuto buoni risultati, mentre anche per lui non c’era rimedio alla progressiva scomparsa della stessa immagine, quando il foglio impresso veniva esposto alla luce. Stanco degli insuccessi, aveva abbandonato la partita, quando gli giunse da Parigi la notizia dello strepitoso successo di Daguerre. Riprese allora gli esperimenti e si accinse a contestare il primato del collega francese, confortato anche da un preziosissimo suggerimento dell’amico William Herschel, che aveva risolto in modo definitivo la difficoltà che aveva bloccato tutti gli esperimenti precedenti. Bastava immergere il foglio di carta, su cui si era formata l’immagine, in una soluzione di iposolfito di sodio (oggi chiamato tiosolfato) e i sali di argento non ancora trasformati dalla luce in granuli di argento annerito si scioglievano e venivano asportati. La carta – per quanto esposta alla luce – non poteva annerirsi ulteriormente. La stabilità dell’immagine era garantita. Talbot chiamava inizialmente le sue immagini con un nome costruito sulla lingua greca: calotipi (dal greco kalos, bello); poi imitò Daguerre e le chiamò talbotipi.
La prima immagine ottenuta dal procedimento Talbot presentava i toni invertiti: il bianco al posto del nero e viceversa. Per ottenere l’immagine corretta egli doveva rendere traslucido con della cera il foglio con l’immagine, sovrapporlo a un altro foglio sensibile ed esporre il tutto alla luce: con lo sviluppo otteneva l’immagine finale. Quello proposto da Talbot è dunque il procedimento fotografico completo: l’immagine prodotta nella camera oscura viene impressa in modo stabile; dalla prima immagine si possono ottenere quante copie si vogliono, tutte identiche alla prima. Questi risultati, però, non avevano la ‘perfezione’ dei dagherrotipi; nei calotipi, infatti, rimaneva visibile la struttura della carta, mentre nel dagherrotipo la grana era praticamente invisibile e dunque l’immagine appariva perfettamente nitida. Il limite venne superato non appena, come supporto, furono adottati il vetro e poi la pellicola di celluloide, ambedue perfettamente trasparenti.
L’elenco dei pionieri della fotografia potrebbe proseguire. Ci fermiamo, ma non senza ritornare a J. F. William Herschel, per l’importanza del suo contributo e per la sua generosità, che lo portò a non rivendicare mai la decisività dei suoi suggerimenti. Non solo era stata sua la proposta di usare l’iposolfito di sodio; fu lui a usare per primo le parole fotografia, fotografico, fotografare (facendo una felice sintesi dei termini usati da Niepce, eliografia, e da Talbot, disegni fotogenici) e i termini negativo e positivo per indicare i due tipi di immagini ottenute da Talbot.
Col chiudersi della prima metà del sec. XIX la fotografia va considerata una conquista definitiva.
Una m.f. era ed è composta essenzialmente da queste parti:
– la camera oscura: cella buia (illuminata da un unico foro) dove si forma l’immagine;
– la superficie sensibile che memorizza l’immagine;
– l’otturatore, sistema di apertura e chiusura del foro della camera oscura (all’inizio un semplice tappo sull’obiettivo);
– l’obiettivo (già nei secoli precedenti, al posto del semplice ‘buco’ la camera oscura prevedeva un vero e proprio obiettivo, che consentiva di mettere a fuoco le immagini).
Possiamo dunque indicare in modo schematico l’evoluzione delle singole parti.
4.1. La camera oscura diventa sempre più piccola e maneggevole.
Si è passati dalla situazione in cui occorreva un carro per portare tutto il necessario, alla minuscola dimensione odierna delle cosiddette macchine usa e getta (per prima la Fuji, nel 1986: pochi centimetri cubi di buio, ricoperto di plastica, sul cui fondo viene fatta passare la pellicola). Determinanti a questo riguardo sono stati il miglioramento qualitativo del materiale sensibile utilizzato (più aumentano la sua qualità e sensibilità, minore è la dimensione del negativo da esporre) e l’interesse dell’industria a rendere popolare l’uso della fotografia.
Emblematica a questo riguardo la macchina messa in vendita negli USA da George Eastman nel 1888 con il nome Kodak: delle dimensioni di circa cm 10 x 10 x 16, era già predisposta per 100 foto. Una volta scattate, il cliente consegnava il tutto al laboratorio, il quale sviluppava le immagini e, insieme alle fotografie, riconsegnava al cliente la macchina pronta per altrettanti nuovi scatti. Efficace lo slogan: Voi premete il bottone, noi faremo il resto.
Un salto di qualità insieme tecnico ed espressivo si è avuto con la comparsa a metà degli anni Venti di due apparecchi fotografici di nuova concezione: nel 1925 l’Ermanox, macchina molto compatta, che poteva usare sia pellicole che lastre, con un’ottica luminosissima per quei tempi (f = 2), tanto da rendere possibili le riprese negli interni senza ricorrere ai lampi di magnesio; l’anno precedente la Leica. Quest’ultima era stata progettata quasi un decennio prima da Oskar Barnack, un tecnico della Leitz: piccola e silenziosa, usava la stessa pellicola del cinema, ma con il fotogramma doppio (24 x 36 mm); se si aggiunge che aveva le ottiche migliori in assoluto e una meccanica perfetta, si può capire come sia stata la macchina più copiata dai concorrenti nella storia della fotografia. Gisèle Freund (1976) afferma che il fotogiornalismo moderno è nato con questi due apparecchi, perché da allora il fotografo ha potuto lavorare ovunque senza che la sua presenza modificasse quanto stava avvenendo; di conseguenza anche le immagini sono cambiate, con un impatto più diretto sul pubblico.
Il dopoguerra ha visto lo sviluppo dell’industria fotografica giapponese: Nikon, Canon, Minolta, Pentax. I primi modelli copiavano letteralmente le migliori macchine tedesche, come fece il Model 1 della Nikon (1948), metà Leica e metà Contax; poi furono sviluppati progetti originali, con una forte integrazione dell’elettronica e all’industria europea non rimase che limitarsi ai prodotti altamente professionali (Hasselblad, Leica) o allearsi con i giapponesi (Contax) per non rischiare di morire.
4.2. La pellicola.
Il materiale sensibile è il settore in cui ci sono stati i cambiamenti più rapidi, con risultati sempre più soddisfacenti. Dalla lastra di rame argentata e dalla carta, si è passati molto presto al vetro ricoperto di una gelatina – il collodio – capace di distribuire in modo uniforme e trattenere sulla lastra i sali di argento. Per funzionare, però, la gelatina doveva essere ancora umida al momento dell’esposizione e quindi ogni fotografo portava con sé tutto il necessario per preparare le sue lastre (tempo disponibile dalla preparazione della lastra allo sviluppo, un quarto d’ora!). Qualche anno dopo si riuscì a lavorare anche con il collodio secco e il bromuro di argento: in questo modo la preparazione del materiale sensibile poteva essere affidata all’industria e il fotografo lo portava con sé già pronto, guadagnando così una notevole libertà di azione. L’idea era stata del medico R. L. Maddox (1871), ma venne portata a pieno sviluppo da un altro inglese, C. H. Bennet, nel 1879. Negli anni 1887-90 il vetro venne sostituito da una pellicola di celluloide, dapprima soltanto piana, poi anche in rotoli.
Contemporaneamente a queste trasformazioni di supporti e tecniche, cambia la sensibilità alla luce del materiale: mentre prima della metà dell’Ottocento per un ritratto occorrevano vari minuti di esposizione, nel 1877 Muybridge fotografa un cavallo al gamoppo usando millesimi di secondo. Migliora anche la definizione con cui vengono resi i particolari e quindi si riducono drasticamente le dimensioni delle lastre e delle stesse macchine. Migliora inoltre la risposta ai singoli colori: le prime lastre erano sensibili solo al blu (il rosso e il verde erano resi con sfumature del nero); nel 1875 si riescono a riprendere le gradazioni del verde, ma è solo con l’adozione della pellicola pancromatica (1906) che il negativo ha un’intensità di annerimento proporzionato alla luminosità dei singoli colori.
La fotografia a colori – dopo numerosi tentativi non del tutto convincenti e non validi dal punto di vista commerciale – è stata messa a punto e diffusa soltanto negli anni Trenta. Il raggiungimento di questo traguardo, perseguito fin dall’inizio della storia della fotografia, si fondava sulla scoperta di J. C. Maxwell, il quale già nel 1861 aveva dimostrato come dai tre colori fondamentali si potessero ottenere tutti gli altri; decisiva era stata anche la messa a punto della pellicola pancromatica, dal momento che una pellicola a colori non è altro che un sandwich di tre strati sensibili di tipo pancromatico, opportunamente protetti da filtri in modo che ricevano solo la luce del colore che devono registrare. Nel 1935 viene commercializzata la Kodachrome; nel 1937 l’Agfachrome.
Rivoluzionaria rispetto a qualsiasi altro ammodernamento la proposta fatta da E. H. Land nel 1947 con l’introduzione della Polaroid. A questo punto il processo di realizzazione di una immagine fotografica non è più diviso in due fasi, la ripresa (il fotografo) e lo sviluppo (in tempi successivi e in laboratorio). Tutto avviene in una fase unica: esposto il materiale sensibile, nella macchina stessa si ottiene sviluppo e fissaggio. Il successo della Polaroid non va misurato solo dal numero di macchine vendute, ma dal fatto che moltissimi strumenti scientifici e medici hanno adottato il materiale a sviluppo immediato.
Negli anni Ottanta si prepara un cambiamento che modificherà tutto il processo fotografico e il rapporto della fotografia con gli altri mezzi di comunicazione: l’adozione del sistema digitale.
In questo caso la superficie sensibile posta in fondo alla ‘camera oscura’ non è composta di granuli argento (milioni per centimetro quadrato), ma da un numero sempre più grande di microricettori di luce, ciascuno dei quali trasforma la luce incidente in un segnale digitale che ne ‘misura’ sia la luminosità sia il tipo di colore. Se questi microricettori (pixel = picture element) sono molto numerosi e il programma del computer sufficientemente potente per registrare una elevatissima gamma di colori (milioni di colori), l’operatore ha un controllo dell’immagine neppure pensabile dal fotografo tradizionale. La fotografia continua a essere composta da un numero grandissimo di punti (ieri granuli di argento oggi pixel); la differenza sta nel fatto che ora ciascuno di quei puntini è perfettamente e totalmente modificabile dall’operatore al computer. L’immagine è poi facilmente trasferibile su linee dedicate e non, immediatamente disponibile per andare in stampa o in Tv o in un programma multimediale.
Probabilmente nel tentativo di non perdere troppo in fretta il mercato amatoriale, di comune accordo, le massime case produttrici nel 1991 hanno messo allo studio non un singolo apparecchio ma un intero sistema dove ogni operazione fosse ottimizzata. Si voleva una macchina compatta, di facile uso (ad esempio nessuna complicazione con l’inserimento della pellicola), che consentisse di cambiare film senza perdita di fotogrammi; una pellicola su cui fossero registrabili delle informazioni utili sia al fotografo che al laboratorio di sviluppo... Nel 1995 all’Expo di Londra venne lanciato l’APS (Advanced Photo System), con l’intera serie dei prodotti, dalle pellicole alle macchine, ai sistemi automatici di sviluppo per i laboratori. A distanza di qualche anno non sembra che il tentativo abbia avuto successo.
Tuttavia il processo fotografico, com’è stato finora, ha gli anni contati. La sfida non è più chimica ma elettronica e matematica, nel senso che la definizione dell’immagine dipende ora dal numero di fotoricettori che si riescono a concentrare per centimetro quadrato (al riguardo non passa giorno che un produttore non si presenti con una macchina migliore di quelle in commercio); dall’altra si deve trovare il modo di memorizzare – in modo efficace e a costi contenuti – la quantità enorme di informazione ottenuta. Lo sviluppo in questo secondo settore va in doppia direzione: da una parte vengono prodotti supporti di memoria sempre più potenti, piccoli ed economici; dall’altra sono messi a punto particolari algoritmi matematici (come il JPEG) capaci di eliminare l’informazione non necessaria (ad esempio quanto l’occhio umano non è in grado di distinguere), di ridurre la ridondanza presente nei dati che formano l’immagine digitale, di ricalcolare l’intera immagine a partire da un ridotto numero di informazioni.
4.3. L’otturatore.
L’otturatore è lo strumento che consente di regolare l’intervallo in cui l’obiettivo rimane aperto. Con l’avvento di materiali sempre più sensibili, molto presto è emersa la necessità di adottare uno strumento meccanico di precisione per misurare il tempo di esposizione della pellicola. Fino a quando l’esposizione durava dei secondi, l’operatore era in grado di intervenire; non più quando l’intervallo è di millesimi di secondo, impossibili da determinare in modo manuale.
Non deve sfuggire l’importanza della rapidità di esposizione di una fotografia. Ciò ha consentito un’analisi molto precisa del movimento: sia del movimento eccessivamente veloce per la percezione umana, sia per il movimento eccessivamente lento. Prima dell’avvento dello strumento fotografico nessuno aveva un’idea precisa dei movimenti delle zampe di un cavallo al galoppo, di come si sviluppa il salto di un uomo, di come vola un uccello, di cosa avviene quando una goccia di latte cade nella tazza sottostante, colma anch’essa di latte (sono tutti riferimenti a fotografie famose, come le 12 immagini di E. Muybridge, del 1877, dal titolo Cavallo al galoppo o la fotografia Salto doppio di Th. Eakins del 1884).
Poiché il controllo del tempo è sempre collegato anche al tipo di diaframma utilizzato (dalla massima apertura consentita, alla minima), a partire dagli anni Cinquanta sono stati messi a punto dei sistemi per un controllo integrato della macchina: misura della luce, sensibilità della pellicola, diaframma, eventuale flash, distanza del soggetto a fuoco. All’inizio erano strumenti di tipo meccanico ed elettrico; oggi, a controllo digitale, sono gestiti da programmi studiati in modo tale da trasferire sulla macchina stessa molte delle capacità operative una volta esclusive del professionista esperto. All’operatore resta una doppia possibilità: lasciar fare alla macchina un’immagine standard (basta inquadrare e premere un pulsante) o realizzare un’immagine che è soltanto sua. In questo caso ha a disposizione uno strumento che risponde con duttilità alle sue esigenze creative: deve comunque conoscere lo strumento altrettanto bene del pittore che usa pennelli e colori.
Il fotografo è realmente un comunicatore che, modellando la luce, le linee, i colori, costruisce un suo testo comunicativo dove gli oggetti perdono la loro materialità per diventare segni; dove vengono integrati i messaggi espressi dalla prossemica, dall’abbigliamento, dalla gestualità, dall’architettura, dalle varie forme di arredamento, in pratica da tutti i codici di comunicazione che utilizzano il canale visivo. La fotografia ricodifica a suo modo messaggi già codificati: è un plagio creativo.
4.4. L’obiettivo.
Anche l’obiettivo ha subito grandi cambiamenti. Non solo in termini di perfezione ottica (è migliore il vetro utilizzato, con indici di trasparenza ottimizzati, con filtri antiriflesso; migliori i calcoli progettuali), ma anche per quanto riguarda la luminosità e l’angolo di visione. La luminosità dell’obiettivo ha reso possibile la ripresa fotografica con livelli diversi di luce o con diaframmi diversi. Per quanto riguarda l’angolo di visione si sono ottenuti i grandangoli – anche molto spinti – come anche i teleobiettivi più estremi.
Tutto questo, abbinato a una sempre più duttile messa a fuoco, anche automatizzata, ha messo in mano al fotografo una macchina che lo sottrae alla creduta automaticità della fotografia.
In realtà non esiste nessuna immagine di un fatto o di un panorama se non negli occhi e nel cervello dell’osservatore. E in questa sua immagine l’osservatore pone gli elementi che ha imparato a selezionare e a prendere in considerazione. Solo in un secondo momento egli realizza dei supporti mnemonici – il disegno, la pittura, più o meno ricchi di informazione – capaci di generare nell’osservatore delle esperienze ricollegabili alla sua stessa visione originale.
La cultura occidentale ci ha insegnato a guardare in un certo modo e noi ci siamo costruiti gli strumenti che producono le immagini che ci siamo abituati a organizzare. La m.f. è il massimo risultato di questo processo, allo stesso tempo frutto e potente rinforzo di un certo modo di vedere.
Chi fa della macchina un suo mezzo espressivo dilata le sue capacità di guardare e di stabilire rapporti tra le cose, concretamente presenti o evocate. In questo senso la m.f. è una grande lente di ingrandimento che sposta i limiti del visibile e insieme un supplemento di memoria. Porta però con sé – e la esalta – una grande illusione, che ci sia concesso un contatto diretto, oggettivo, con la realtà, non mediato dalla cultura in cui ci siamo formati. Come se una fotografia fosse ‘impronta’, ‘specchio’ della realtà. Tutto ciò che essa può fare è registrare – secondo programma – i riflessi con cui la luce gioca sulla superficie delle cose. Ciò che sta al di là della superficie non le è consentito indicarlo: può essere solo evocato. Ma questo non è la macchina a farlo, è l’uomo che vuole capire, capirsi e comunicare. Chi schiaccia il pulsante diventa così autore delle sue fotografie solo se riesce a dare visibilità a quanto gli altri non vedono. Tutto il resto la macchina è in grado di farlo da sola (o quasi).
1. Novità
La sua messa a punto nella prima metà dell’Ottocento ha determinato un vero salto di qualità nel modo in cui l’uomo controlla le informazioni provenienti dall’ambiente. Prima della m.f. esse dovevano essere elaborate dall’uomo e poi ‘registrate’ con mezzi mnemonici come sono le varie forme di scrittura, il disegno, la pittura, i nodi a una cordicella... Per ‘leggere’ questi testi occorrevano e occorrono lettori addestrati alla elaborazione di codici particolari: ad esempio per ‘leggere’ il segno grafico ‘sale’ non basta conoscere l’alfabeto latino, dal momento che la parola non ha un solo significato per gli italiani (elemento chimico oppure voce del verbo salire), ne ha uno completamente diverso per gli inglesi (lastra di vetro) e così per gli spagnoli (egli esce) e per i francesi (sporco, lercio). Con la m.f. si mette a punto il primo di una serie di strumenti in grado di raccogliere dall’ambiente, organizzare e memorizzare un numero altissimo di informazioni ottiche secondo modalità programmate dal nostro sviluppo culturale/tecnologico e dal singolo operatore, ma in modo tale che l’esito risulta leggibile da parte di quanti – appartenenti allo stesso ambito culturale – avrebbero letto le stesse informazioni se posti di fronte all’oggetto ripreso. L’agricoltore, che sa distinguere un fiore di melo da un fiore di pesco, lo sa fare anche di fronte alle corrispettive fotografie, salvo il caso in cui il fotografo abbia voluto mascherare volutamente le differenze. (Per quanto riguarda la pretesa universalità del linguaggio fotografico si veda la voce Fotografia).Dopo la m.f., per le stesse informazioni di tipo visivo sono arrivati la cinepresa e l’ ologramma; per le informazioni sonore il microfono, il disco, il registratore, il CD, il MiniDisc; per le informazioni di tipo ottico e uditivo insieme, la telecamera e la televisione, con il videoregistratore, analogico prima e poi digitale.
Con il miglioramento della strumentazione la m.f. ha di fatto allargato il campo visivo dell’uomo: non solo perché gli ha consentito di osservare con molta più accuratezza moltissimi fenomeni, ma perché lo ha messo in grado di esplorare l’immensamente piccolo, come l’immensamente grande, assumendo punti di vista altrimenti impossibili (gli esami endoscopici, ad esempio, oppure il controllo di situazioni pericolose); ha reso ‘visibili’ fenomeni che si verificano in tempi brevissimi, dilatandone in forma virtuale la durata o, viceversa, fenomeni lentissimi concentrando in brevi sequenze quanto avviene in giorni o mesi. Della tecnica di riproduzione fotografica – ingrandimento e riduzione – non ha beneficiato soltanto la stampa in tutte le sue forme, ma anche la tecnica, in modo particolare la microelettronica per la produzione dei circuiti integrati che rendono ‘intelligenti’ le macchine oggi a nostra disposizione (non solo i computer, ma tutte le macchine con forme di autocontrollo, dalla lavastoviglie al videoregistratore).
2. Le matrici culturali dell’invenzione
Non è possibile attribuire la paternità dell’invenzione della m.f. a una singola persona. Se poi si prende in considerazione l’apparecchio che oggi abbiamo a disposizione, non si può non affermare che si tratta di una invenzione ‘collettiva’. Evidenziamo gli apporti più significativi.a) La camera oscura era un fenomeno conosciuto da oltre un millennio. Divenne oggetto di interesse crescente quando il pensiero filosofico e scientifico occidentale – è l’età del rinascimento – adotta una concezione che pone al centro dell’universo un solo punto di vista, quello dell’uomo, inteso come misura di tutte le cose (nasce la scienza moderna). La prospettiva diventa l’unico modello di rappresentazione della realtà, inteso come struttura geometrica che organizza ogni informazione visiva. Il fatto che la camera oscura desse un’immagine della realtà giudicata perfetta, e questo in modo automatico, ha determinato il successo di questo strumento presso tutti gli interessati a usare il disegno per memorizzare un’esperienza visiva. La conseguenza è stata che il modello prospettico è diventato per l’Occidente lo schema visivo naturale, scientifico: rappresentare la realtà in modo diverso è semplicemente sbagliato. Di qui la reazione degli artisti della seconda parte del secolo scorso e di questo secolo, i quali hanno disatteso e reinterpretato le leggi della prospettiva per esprimere modi diversi di sentire la realtà. Come conseguenza si consolida la convinzione che la fotografia connota oggettività, verità, mentre l’arte è considerata operazione soggettiva, astratta, effimera.
b) La stampa a caratteri mobili – con nuove forme di utilizzazione della xilografia prima e della litografia poi per la produzione delle immagini – aveva già messo a disposizione la tecnica per produrre non dei singoli esemplari ma un numero indefinito di copie perfettamente uguali una all’altra ( Tipografia). Il punto di partenza rimane però sempre l’opera di un artista o di un tecnico, il quale pazientemente sa riprodurre i tratti di un disegno o di una pittura in righe e superfici in rilievo, dove l’inchiostro si ferma in modo da impregnare poi la carta.
c) Alla fine del Settecento e all’inizio dell’Ottocento sono molti coloro che si pongono il problema della riproduzione automatica del disegno o dell’immagine che si ottiene sul fondo della camera oscura. E questo è importante, perché il primo passo di ogni invenzione è la corretta formulazione del problema. Così il litografo era alla ricerca di un metodo che gli consentisse di trasferire automaticamente un’immagine sulla pietra (i fratelli Niepce, fisici e chimici francesi, lavoravano, tra l’altro, al miglioramento del processo litografico, introdotto in Francia nel 1815); c’era chi utilizzava la camera oscura per riprodurre un paesaggio su tela o per dipingere i fondali di uno spettacolo teatrale (il Diorama di Daguerre a Parigi si basava su giochi di luci e trasparenze di scenari riproducenti paesaggi concreti, riconoscibili); c’era anche chi, senza riuscirci troppo bene, utilizzava la camera chiara per documentare i suoi viaggi (era il 1833 quando l’inglese Talbot, di fronte alla bellezza del lago di Como e alla propria incapacità di tradurre lo spettacolo in un disegno, decise di studiare come ottenere immagini in modo ‘automatico’).
d) La scienza già da tempo aveva individuato alcuni fenomeni risultati poi decisivi. Che i sali di argento si annerissero sotto l’effetto della luce lo si era osservato già nel 1560; la prova era stata ottenuta da J. H. Schulze nel 1727; anche l’effetto di indurimento provocato dalla luce sul bitume di Giudea non era una novità; che l’iposolfito di sodio sciogliesse i sali di argento l’astronomo e scienziato J. F. W. Herschel l’aveva notato nel 1816.
All’inizio del sec. XIX, dunque, c’erano a disposizione tanti tasselli privi di relazione tra loro. Attraverso prove ed errori, risultati perseguiti intenzionalmente oppure ottenuti in modo casuale, suggerimenti e veri furti di idee, quei tasselli si sono riuniti a formare un puzzle sempre più coerente ed efficace, riuscendo a definire il processo fotografico.
3. I pionieri
Nel 1802 un giovane inglese, Th. Wedgwood, che lavora nella pittura di ceramiche e per questo utilizza la camera oscura, annuncia di essere riuscito a ottenere delle immagini utilizzando il nitrato di argento. Sono però immagini che non durano nel tempo e dunque il procedimento non si afferma.Probabilmente sono invece Joseph-Nicéphore e Claude Niepce i primi a ottenere dei risultati concreti e stabili. Essi già dal 1815 stanno lavorando su un procedimento che chiamano ‘eliografia’ (scrittura del sole) sia per riprodurre ‘automaticamente’ un’immagine come matrice per il processo litografico, sia per fissare l’immagine che si forma nella camera oscura. La loro ricerca e gli esperimenti continuano fino al 1833, data della morte del più attivo dei due fratelli, Joseph-Nicéphore. Del 1827 è la loro eliografia più bella a noi pervenuta, in cui è ripresa una tavola apparecchiata (per ottenere quell’immagine fu necessaria un’esposizione di otto ore).
Un altro francese, Louis Jacques Mandé Daguerre, usa la camera oscura per disegnare i fondali del suo spettacolo. Nel 1827 viene a sapere – dal tecnico che gli fornisce l’apparecchiatura – degli esperimenti e dei risultati dei Niepce. Si dà da fare per incontrare Joseph-Nicéphore, mentre è a Parigi di ritorno da un viaggio in Inghilterra. Quando sa che sta per pubblicare un libro sulle sue ricerche lo sconsiglia e, millantando successi suoi nello stesso ambito, riesce a convincerlo a fondare una società (la Niepce-Daguerre) per sfruttare un’invenzione che pensa già a portata di mano. Gli esperimenti continuano senza veri progressi, anche dopo la morte di Niepce. Il problema insoluto è sempre lo stesso: come far durare l’immagine, bloccando l’effetto della luce sui sali d’argento? In pratica l’immagine si forma, ma deve essere osservata nella penombra e, in ogni caso, dopo un certo tempo, essa viene cancellata dall’annerimento di tutta la superficie. Nel 1837 Daguerre risolve in parte il problema e ottiene delle immagini particolarmente valide per l’esattezza dei particolari e per l’ampia gamma di grigi con cui sono riprodotte luci e ombre. Nel 1839 annuncia l’invenzione come se fosse soltanto sua e, grazie all’appoggio di François Arago, segretario dell’Accademia delle Scienze e deputato, ottiene dal governo francese un sostanzioso vitalizio in cambio della pubblicazione dell’invenzione presentata come una grande conquista della scienza francese.
Il dagherrotipo – come Daguerre si affretta a chiamare il nuovo tipo di immagine – è una lastra di rame, argentata e tirata a lucido; viene esposta a vapori di iodio (la superficie si modifica in uno strato sottilissimo di sali di argento) e quindi inserita nella camera oscura, per la ripresa vera e propria, per un tempo non particolarmente lungo. L’immagine che si forma sulla sua superficie non è immediatamente visibile; lo diventa sotto l’effetto del vapore di mercurio, che si amalgama all’argento prodottosi sulla lastra per effetto della luce. Il tutto viene immerso in una soluzione concentrata di sale marino che si è dimostrato capace di ridurre notevolmente la fotosensibilità dei sali d’argento rimasti sulla lastra. Il risultato è un’immagine impressionante per il dettaglio e la resa dei contrasti luminosi; è tuttavia visibile solo se si inclina la lastra secondo un certo angolo rispetto alla luce. È un esemplare unico, non moltiplicabile. Per questo la soluzione proposta da Daguerre non può essere considerata a tutti gli effetti l’invenzione del processo fotografico, il quale consiste in due fasi tra loro complementari: la produzione dell’immagine e la sua riproducibilità in tanti esemplari, tutti identici.
In quelli stessi anni in Inghilterra lavorava alla soluzione del problema anche W. H. Fox Talbot. Seguiva però un procedimento assai diverso. Nella camera oscura esponeva alla luce un foglio di carta preparato con un preciso procedimento: dopo essere stato immerso in una soluzione di sale marino, una volta asciutto veniva imbevuto di una sospensione di sali di argento. Per quanto riguarda la produzione dell’immagine, Talbot aveva ottenuto buoni risultati, mentre anche per lui non c’era rimedio alla progressiva scomparsa della stessa immagine, quando il foglio impresso veniva esposto alla luce. Stanco degli insuccessi, aveva abbandonato la partita, quando gli giunse da Parigi la notizia dello strepitoso successo di Daguerre. Riprese allora gli esperimenti e si accinse a contestare il primato del collega francese, confortato anche da un preziosissimo suggerimento dell’amico William Herschel, che aveva risolto in modo definitivo la difficoltà che aveva bloccato tutti gli esperimenti precedenti. Bastava immergere il foglio di carta, su cui si era formata l’immagine, in una soluzione di iposolfito di sodio (oggi chiamato tiosolfato) e i sali di argento non ancora trasformati dalla luce in granuli di argento annerito si scioglievano e venivano asportati. La carta – per quanto esposta alla luce – non poteva annerirsi ulteriormente. La stabilità dell’immagine era garantita. Talbot chiamava inizialmente le sue immagini con un nome costruito sulla lingua greca: calotipi (dal greco kalos, bello); poi imitò Daguerre e le chiamò talbotipi.
La prima immagine ottenuta dal procedimento Talbot presentava i toni invertiti: il bianco al posto del nero e viceversa. Per ottenere l’immagine corretta egli doveva rendere traslucido con della cera il foglio con l’immagine, sovrapporlo a un altro foglio sensibile ed esporre il tutto alla luce: con lo sviluppo otteneva l’immagine finale. Quello proposto da Talbot è dunque il procedimento fotografico completo: l’immagine prodotta nella camera oscura viene impressa in modo stabile; dalla prima immagine si possono ottenere quante copie si vogliono, tutte identiche alla prima. Questi risultati, però, non avevano la ‘perfezione’ dei dagherrotipi; nei calotipi, infatti, rimaneva visibile la struttura della carta, mentre nel dagherrotipo la grana era praticamente invisibile e dunque l’immagine appariva perfettamente nitida. Il limite venne superato non appena, come supporto, furono adottati il vetro e poi la pellicola di celluloide, ambedue perfettamente trasparenti.
L’elenco dei pionieri della fotografia potrebbe proseguire. Ci fermiamo, ma non senza ritornare a J. F. William Herschel, per l’importanza del suo contributo e per la sua generosità, che lo portò a non rivendicare mai la decisività dei suoi suggerimenti. Non solo era stata sua la proposta di usare l’iposolfito di sodio; fu lui a usare per primo le parole fotografia, fotografico, fotografare (facendo una felice sintesi dei termini usati da Niepce, eliografia, e da Talbot, disegni fotogenici) e i termini negativo e positivo per indicare i due tipi di immagini ottenute da Talbot.
Col chiudersi della prima metà del sec. XIX la fotografia va considerata una conquista definitiva.
4. Gli sviluppi
È impossibile nello spazio di alcune colonne seguire gli sviluppi della m.f. Possiamo però farcene un’idea individuando i vari settori in cui gli sviluppi si sono realizzati.Una m.f. era ed è composta essenzialmente da queste parti:
– la camera oscura: cella buia (illuminata da un unico foro) dove si forma l’immagine;
– la superficie sensibile che memorizza l’immagine;
– l’otturatore, sistema di apertura e chiusura del foro della camera oscura (all’inizio un semplice tappo sull’obiettivo);
– l’obiettivo (già nei secoli precedenti, al posto del semplice ‘buco’ la camera oscura prevedeva un vero e proprio obiettivo, che consentiva di mettere a fuoco le immagini).
Possiamo dunque indicare in modo schematico l’evoluzione delle singole parti.
4.1. La camera oscura diventa sempre più piccola e maneggevole.
Si è passati dalla situazione in cui occorreva un carro per portare tutto il necessario, alla minuscola dimensione odierna delle cosiddette macchine usa e getta (per prima la Fuji, nel 1986: pochi centimetri cubi di buio, ricoperto di plastica, sul cui fondo viene fatta passare la pellicola). Determinanti a questo riguardo sono stati il miglioramento qualitativo del materiale sensibile utilizzato (più aumentano la sua qualità e sensibilità, minore è la dimensione del negativo da esporre) e l’interesse dell’industria a rendere popolare l’uso della fotografia.
Emblematica a questo riguardo la macchina messa in vendita negli USA da George Eastman nel 1888 con il nome Kodak: delle dimensioni di circa cm 10 x 10 x 16, era già predisposta per 100 foto. Una volta scattate, il cliente consegnava il tutto al laboratorio, il quale sviluppava le immagini e, insieme alle fotografie, riconsegnava al cliente la macchina pronta per altrettanti nuovi scatti. Efficace lo slogan: Voi premete il bottone, noi faremo il resto.
Un salto di qualità insieme tecnico ed espressivo si è avuto con la comparsa a metà degli anni Venti di due apparecchi fotografici di nuova concezione: nel 1925 l’Ermanox, macchina molto compatta, che poteva usare sia pellicole che lastre, con un’ottica luminosissima per quei tempi (f = 2), tanto da rendere possibili le riprese negli interni senza ricorrere ai lampi di magnesio; l’anno precedente la Leica. Quest’ultima era stata progettata quasi un decennio prima da Oskar Barnack, un tecnico della Leitz: piccola e silenziosa, usava la stessa pellicola del cinema, ma con il fotogramma doppio (24 x 36 mm); se si aggiunge che aveva le ottiche migliori in assoluto e una meccanica perfetta, si può capire come sia stata la macchina più copiata dai concorrenti nella storia della fotografia. Gisèle Freund (1976) afferma che il fotogiornalismo moderno è nato con questi due apparecchi, perché da allora il fotografo ha potuto lavorare ovunque senza che la sua presenza modificasse quanto stava avvenendo; di conseguenza anche le immagini sono cambiate, con un impatto più diretto sul pubblico.
Il dopoguerra ha visto lo sviluppo dell’industria fotografica giapponese: Nikon, Canon, Minolta, Pentax. I primi modelli copiavano letteralmente le migliori macchine tedesche, come fece il Model 1 della Nikon (1948), metà Leica e metà Contax; poi furono sviluppati progetti originali, con una forte integrazione dell’elettronica e all’industria europea non rimase che limitarsi ai prodotti altamente professionali (Hasselblad, Leica) o allearsi con i giapponesi (Contax) per non rischiare di morire.
4.2. La pellicola.
Il materiale sensibile è il settore in cui ci sono stati i cambiamenti più rapidi, con risultati sempre più soddisfacenti. Dalla lastra di rame argentata e dalla carta, si è passati molto presto al vetro ricoperto di una gelatina – il collodio – capace di distribuire in modo uniforme e trattenere sulla lastra i sali di argento. Per funzionare, però, la gelatina doveva essere ancora umida al momento dell’esposizione e quindi ogni fotografo portava con sé tutto il necessario per preparare le sue lastre (tempo disponibile dalla preparazione della lastra allo sviluppo, un quarto d’ora!). Qualche anno dopo si riuscì a lavorare anche con il collodio secco e il bromuro di argento: in questo modo la preparazione del materiale sensibile poteva essere affidata all’industria e il fotografo lo portava con sé già pronto, guadagnando così una notevole libertà di azione. L’idea era stata del medico R. L. Maddox (1871), ma venne portata a pieno sviluppo da un altro inglese, C. H. Bennet, nel 1879. Negli anni 1887-90 il vetro venne sostituito da una pellicola di celluloide, dapprima soltanto piana, poi anche in rotoli.
Contemporaneamente a queste trasformazioni di supporti e tecniche, cambia la sensibilità alla luce del materiale: mentre prima della metà dell’Ottocento per un ritratto occorrevano vari minuti di esposizione, nel 1877 Muybridge fotografa un cavallo al gamoppo usando millesimi di secondo. Migliora anche la definizione con cui vengono resi i particolari e quindi si riducono drasticamente le dimensioni delle lastre e delle stesse macchine. Migliora inoltre la risposta ai singoli colori: le prime lastre erano sensibili solo al blu (il rosso e il verde erano resi con sfumature del nero); nel 1875 si riescono a riprendere le gradazioni del verde, ma è solo con l’adozione della pellicola pancromatica (1906) che il negativo ha un’intensità di annerimento proporzionato alla luminosità dei singoli colori.
La fotografia a colori – dopo numerosi tentativi non del tutto convincenti e non validi dal punto di vista commerciale – è stata messa a punto e diffusa soltanto negli anni Trenta. Il raggiungimento di questo traguardo, perseguito fin dall’inizio della storia della fotografia, si fondava sulla scoperta di J. C. Maxwell, il quale già nel 1861 aveva dimostrato come dai tre colori fondamentali si potessero ottenere tutti gli altri; decisiva era stata anche la messa a punto della pellicola pancromatica, dal momento che una pellicola a colori non è altro che un sandwich di tre strati sensibili di tipo pancromatico, opportunamente protetti da filtri in modo che ricevano solo la luce del colore che devono registrare. Nel 1935 viene commercializzata la Kodachrome; nel 1937 l’Agfachrome.
Rivoluzionaria rispetto a qualsiasi altro ammodernamento la proposta fatta da E. H. Land nel 1947 con l’introduzione della Polaroid. A questo punto il processo di realizzazione di una immagine fotografica non è più diviso in due fasi, la ripresa (il fotografo) e lo sviluppo (in tempi successivi e in laboratorio). Tutto avviene in una fase unica: esposto il materiale sensibile, nella macchina stessa si ottiene sviluppo e fissaggio. Il successo della Polaroid non va misurato solo dal numero di macchine vendute, ma dal fatto che moltissimi strumenti scientifici e medici hanno adottato il materiale a sviluppo immediato.
Negli anni Ottanta si prepara un cambiamento che modificherà tutto il processo fotografico e il rapporto della fotografia con gli altri mezzi di comunicazione: l’adozione del sistema digitale.
In questo caso la superficie sensibile posta in fondo alla ‘camera oscura’ non è composta di granuli argento (milioni per centimetro quadrato), ma da un numero sempre più grande di microricettori di luce, ciascuno dei quali trasforma la luce incidente in un segnale digitale che ne ‘misura’ sia la luminosità sia il tipo di colore. Se questi microricettori (pixel = picture element) sono molto numerosi e il programma del computer sufficientemente potente per registrare una elevatissima gamma di colori (milioni di colori), l’operatore ha un controllo dell’immagine neppure pensabile dal fotografo tradizionale. La fotografia continua a essere composta da un numero grandissimo di punti (ieri granuli di argento oggi pixel); la differenza sta nel fatto che ora ciascuno di quei puntini è perfettamente e totalmente modificabile dall’operatore al computer. L’immagine è poi facilmente trasferibile su linee dedicate e non, immediatamente disponibile per andare in stampa o in Tv o in un programma multimediale.
Probabilmente nel tentativo di non perdere troppo in fretta il mercato amatoriale, di comune accordo, le massime case produttrici nel 1991 hanno messo allo studio non un singolo apparecchio ma un intero sistema dove ogni operazione fosse ottimizzata. Si voleva una macchina compatta, di facile uso (ad esempio nessuna complicazione con l’inserimento della pellicola), che consentisse di cambiare film senza perdita di fotogrammi; una pellicola su cui fossero registrabili delle informazioni utili sia al fotografo che al laboratorio di sviluppo... Nel 1995 all’Expo di Londra venne lanciato l’APS (Advanced Photo System), con l’intera serie dei prodotti, dalle pellicole alle macchine, ai sistemi automatici di sviluppo per i laboratori. A distanza di qualche anno non sembra che il tentativo abbia avuto successo.
Tuttavia il processo fotografico, com’è stato finora, ha gli anni contati. La sfida non è più chimica ma elettronica e matematica, nel senso che la definizione dell’immagine dipende ora dal numero di fotoricettori che si riescono a concentrare per centimetro quadrato (al riguardo non passa giorno che un produttore non si presenti con una macchina migliore di quelle in commercio); dall’altra si deve trovare il modo di memorizzare – in modo efficace e a costi contenuti – la quantità enorme di informazione ottenuta. Lo sviluppo in questo secondo settore va in doppia direzione: da una parte vengono prodotti supporti di memoria sempre più potenti, piccoli ed economici; dall’altra sono messi a punto particolari algoritmi matematici (come il JPEG) capaci di eliminare l’informazione non necessaria (ad esempio quanto l’occhio umano non è in grado di distinguere), di ridurre la ridondanza presente nei dati che formano l’immagine digitale, di ricalcolare l’intera immagine a partire da un ridotto numero di informazioni.
4.3. L’otturatore.
L’otturatore è lo strumento che consente di regolare l’intervallo in cui l’obiettivo rimane aperto. Con l’avvento di materiali sempre più sensibili, molto presto è emersa la necessità di adottare uno strumento meccanico di precisione per misurare il tempo di esposizione della pellicola. Fino a quando l’esposizione durava dei secondi, l’operatore era in grado di intervenire; non più quando l’intervallo è di millesimi di secondo, impossibili da determinare in modo manuale.
Non deve sfuggire l’importanza della rapidità di esposizione di una fotografia. Ciò ha consentito un’analisi molto precisa del movimento: sia del movimento eccessivamente veloce per la percezione umana, sia per il movimento eccessivamente lento. Prima dell’avvento dello strumento fotografico nessuno aveva un’idea precisa dei movimenti delle zampe di un cavallo al galoppo, di come si sviluppa il salto di un uomo, di come vola un uccello, di cosa avviene quando una goccia di latte cade nella tazza sottostante, colma anch’essa di latte (sono tutti riferimenti a fotografie famose, come le 12 immagini di E. Muybridge, del 1877, dal titolo Cavallo al galoppo o la fotografia Salto doppio di Th. Eakins del 1884).
Poiché il controllo del tempo è sempre collegato anche al tipo di diaframma utilizzato (dalla massima apertura consentita, alla minima), a partire dagli anni Cinquanta sono stati messi a punto dei sistemi per un controllo integrato della macchina: misura della luce, sensibilità della pellicola, diaframma, eventuale flash, distanza del soggetto a fuoco. All’inizio erano strumenti di tipo meccanico ed elettrico; oggi, a controllo digitale, sono gestiti da programmi studiati in modo tale da trasferire sulla macchina stessa molte delle capacità operative una volta esclusive del professionista esperto. All’operatore resta una doppia possibilità: lasciar fare alla macchina un’immagine standard (basta inquadrare e premere un pulsante) o realizzare un’immagine che è soltanto sua. In questo caso ha a disposizione uno strumento che risponde con duttilità alle sue esigenze creative: deve comunque conoscere lo strumento altrettanto bene del pittore che usa pennelli e colori.
Il fotografo è realmente un comunicatore che, modellando la luce, le linee, i colori, costruisce un suo testo comunicativo dove gli oggetti perdono la loro materialità per diventare segni; dove vengono integrati i messaggi espressi dalla prossemica, dall’abbigliamento, dalla gestualità, dall’architettura, dalle varie forme di arredamento, in pratica da tutti i codici di comunicazione che utilizzano il canale visivo. La fotografia ricodifica a suo modo messaggi già codificati: è un plagio creativo.
4.4. L’obiettivo.
Anche l’obiettivo ha subito grandi cambiamenti. Non solo in termini di perfezione ottica (è migliore il vetro utilizzato, con indici di trasparenza ottimizzati, con filtri antiriflesso; migliori i calcoli progettuali), ma anche per quanto riguarda la luminosità e l’angolo di visione. La luminosità dell’obiettivo ha reso possibile la ripresa fotografica con livelli diversi di luce o con diaframmi diversi. Per quanto riguarda l’angolo di visione si sono ottenuti i grandangoli – anche molto spinti – come anche i teleobiettivi più estremi.
Tutto questo, abbinato a una sempre più duttile messa a fuoco, anche automatizzata, ha messo in mano al fotografo una macchina che lo sottrae alla creduta automaticità della fotografia.
5. Non solo immagini
Per un osservatore ingenuo la m.f. è uno strumento che fornisce immagini oggettive della realtà. Dicendo questo egli muove dal presupposto che le immagini abbiano una loro autonomia, che esistano indipendentemente da un osservatore; quasi esistessero degli specchi invisibili dove esse si formano. La macchina si limiterebbe a catturare queste immagini.In realtà non esiste nessuna immagine di un fatto o di un panorama se non negli occhi e nel cervello dell’osservatore. E in questa sua immagine l’osservatore pone gli elementi che ha imparato a selezionare e a prendere in considerazione. Solo in un secondo momento egli realizza dei supporti mnemonici – il disegno, la pittura, più o meno ricchi di informazione – capaci di generare nell’osservatore delle esperienze ricollegabili alla sua stessa visione originale.
La cultura occidentale ci ha insegnato a guardare in un certo modo e noi ci siamo costruiti gli strumenti che producono le immagini che ci siamo abituati a organizzare. La m.f. è il massimo risultato di questo processo, allo stesso tempo frutto e potente rinforzo di un certo modo di vedere.
Chi fa della macchina un suo mezzo espressivo dilata le sue capacità di guardare e di stabilire rapporti tra le cose, concretamente presenti o evocate. In questo senso la m.f. è una grande lente di ingrandimento che sposta i limiti del visibile e insieme un supplemento di memoria. Porta però con sé – e la esalta – una grande illusione, che ci sia concesso un contatto diretto, oggettivo, con la realtà, non mediato dalla cultura in cui ci siamo formati. Come se una fotografia fosse ‘impronta’, ‘specchio’ della realtà. Tutto ciò che essa può fare è registrare – secondo programma – i riflessi con cui la luce gioca sulla superficie delle cose. Ciò che sta al di là della superficie non le è consentito indicarlo: può essere solo evocato. Ma questo non è la macchina a farlo, è l’uomo che vuole capire, capirsi e comunicare. Chi schiaccia il pulsante diventa così autore delle sue fotografie solo se riesce a dare visibilità a quanto gli altri non vedono. Tutto il resto la macchina è in grado di farlo da sola (o quasi).
Video
Non ci sono video per questa voce
Bibliografia
- BENJAMIN Walter, Piccola storia della fotografia in BENJAMIN Walter (ed. by), L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1991 (ed. orig. 1936).
- BURIAN Peter K. - CAPUTO Robert, Corso di fotografia. Tutti i segreti per scattare grandi immagini, National Geographic Society - Ed. La Repubblica, Roma 2000.
- CAPOBUSSI Maurizio, Fotografia. Conoscere e praticare la fotografia, dai metodi tradizionali a quelli digitali, De Agostini, Novara 1999.
- FREUND Gisele, Fotografia e società. Riflessione critica ed esperienza pratica di un'allieva di Adorno, Einaudi, Torino 1976.
- FRIZOT Michel (ed.), Nouvelle histoire de la photographie, Bordas, Paris 1994.
- HEDGECOE John, Il manuale del fotografo, Mondadori, Milano 1993.
- LANGFORD Michael J., Story of photography. From its beginnings to the present day, Focal Press, Boston (MA) 1997.
- LISTER Martin, The photographic image in digital culture, Routledge, London 1995.
- MORMORIO Diego, Storia della fotografia, Tascabili Economici Newton, Milano 1996.
- NEWHALL Beaumont, Storia della fotografia, Einaudi, Torino 1984.
- SCHAAF Larry John, Out of the shadows. Herschel, Talbot and the invention of photography, Yale University Press, London 1992.
- SETTIMELLI Wladimiro, I padri della fotografia. I fatti, i pionieri, gli eroi, le polemiche, le tecniche e i documenti inediti dal 1820, C. Ciapanna, Roma 1979.
- TAUSK Petr, Storia della fotografia del 20° secolo, G. Mazzotta, Milano 1980.
- ZANNIER Italo, La fotografia italiana. Critica e storia, Jaca Book, Milano 1994.
Documenti
Non ci sono documenti per questa voce
Links
Come citare questa voce
Lever Franco , Macchina fotografica, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (17/08/2025).
 Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SA
Il testo è disponibile secondo la licenza CC-BY-NC-SACreative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo
763